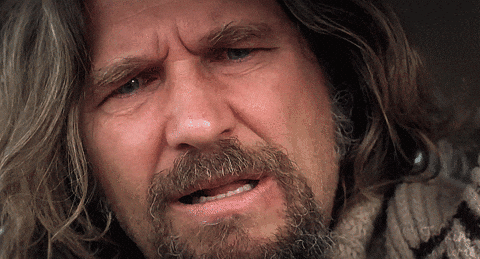È finita.
I quaranta giorni sono giunti al termine, è il caso di tirare un po' le somme di questo Social Detox.
I quaranta giorni sono giunti al termine, è il caso di tirare un po' le somme di questo Social Detox.
Innanzitutto, sto scrivendo: apprendo quindi sulla mia pelle che sopravvivere mi è possibile.
Oh quale gaudio! Oh quale sollievo all'idea che questo temutissimo Kraken digitale sia affrontabile! Già solo per questo ritengo sia valsa la pena di aver intrapreso l'esperimento.
In secondo luogo: non sono arrivata alla fine essendomi strappata i capelli, scorticata le braccia in preda al prurito o senza più le unghie. Ci sono arrivata con tranquillo agio. All'inizio avevo cominciato a scrivere dei piccoli appunti ogni volta che notavo qualcosa di particolare:
Giorno 1
"Ho addirittura anticipato l'attuazione rispetto alla deadline stabilita. Momento di panico subito prima di cliccare su 'disattiva': sarà davvero una misura solo temporanea? G., per non rischiare, mi propone la soluzione alternativa di cambiare lui la mia password. Eh no, cavolo, deve essere una cosa che faccio da me. Ricontrollo la procedura (mi sento ridicola). Nel frattempo Facebook cerca in tutti i modi di convincermi a non farlo, puntando anche sul senso di colpa ('a questi amici mancherai!') o proponendo soluzioni più blande.
Scopro che per riattivare gli account del gruppo Facebook, basta semplicemente riaccedervi: mi sembra una misura un po' debole. Scopro anche che Twitter, dopo 30 giorni di sospensione, elimina definitivamente l'account. Promemoria sul Calendar, servirà un breve accesso anticipato.
Sera, G. è ri-partito. Incredibilmente, mi sembra di avere moltissimo tempo in più a disposizione tra le mani, senza social. Quasi troppo."
Giorno 2
"Le mie dita cercano automaticamente di accedere alle applicazioni sul telefono (disinstallate): quante migliaia di volte avrò compiuto lo stesso gesto, per farglielo fare quando sono sovrappensiero?"
Giorno 3
"Quando sono al computer, il mouse finisce spesso a cercare il link diretto a Facebook (cancellato).
N.B. dormo meglio."
Giorno 4
"Per lavoro devo contattare un ex dottorando. Non ho il suo nuovo indirizzo e-mail, ma siamo amici su Facebook. Oh-oh.
Meno male che ho lasciato l'accesso a Messenger."
Giorno 5
"È tornato il controllo sull'utilizzo dei dati. Addio."
Questo ha bisogno di qualche spiegazione: essendo in una residenza dell'Università, la rete internet è, sorpresa!, gestita dall'Università. C'è un limite di consumo dati, fissato a 25 Giga ogni 8 giorni: superato il limite, l'accesso ad internet è ristretto a siti riguardanti l'ateneo. Ad un certo punto, circa un anno e mezzo fa, un po' per caso avevo by-passato questo problema, ma devono aver aggiornato il sistema e lo stesso espediente non funziona più.
Ora, senza più i social avevo intenzione di ripartire il tempo guadagnato tra letture e recupero di serie su Netflix o di video interessanti su Youtube, ma i 25 Giga scorrono via come acqua. Quindi niente, libri a go-go!*
E poi non ho più annotato nulla: dopo i primi giorni di assestamento, non c'è stato più bisogno.
- Si, ok, ma quindi? In sostanza?
In sostanza, i quaranta giorni sono arrivati e passati, e io ancora non ho riattivato gli account. Sono stata talmente tanto bene senza, che ho quasi paura a rientrare nel circolo vizioso.
Da un punto di vista pratico, l'assenza in particolare di Facebook si è fatta sentire: ci sono stati svariati momenti in cui segnarsi un evento (e ricordarsene!) sarebbe stato molto più facile semplicemente cliccando su "Partecipa". Sono stati numerosi i "ah già, volevo farti vedere questa cosa/giusto, non puoi saperlo/hai visto cosa è successo?". Ma è stato così problematico? Non particolarmente. Forse vale la pena doversi scrivere a mano qualche cosa in più o dover dipendere da altri per avere determinate informazioni, se la ricompensa è un po' di pace interiore.
Psicologicamente parlando, che pacchia!, che rilassatezza! Avrò anche perso degli aggiornamenti sulla vita dei miei contatti, ma quelle due o tre cose importanti che sono successe le ho vissute (da lontano) lo stesso, e con molta più tranquillità. Che poi, quanti di questi aggiornamenti sono davvero importanti? E lo dico anche pensando ai miei, eh! Quante di queste cose vale davvero la pena sapere? Durante questo periodo mi sono chiesta se ci prenderemmo la briga di raccontare a voce in una conversazione tutto ciò che pubblichiamo in giro sulle varie piattaforme, e la risposta è che probabilmente no. Potrebbe essere un buon criterio, un po' per tutti, per discernere ciò che è valido o meno: non che sia una condizione sufficiente, non è obbligatorio condividere cose della propria vita. Ma allora che senso hanno i social?
Mi sto interrogando da un po' sulla questione, e ancora non ho trovato una risposta precisa. Motivo per il quale credo che continuerò a tenere gli account in sospeso sine die: anche qua, che cosa psicologicamente bizzarra. Perché non dovrei eliminarli definitivamente? Immagino ci sia una componente legata al fatto di avere delle sorte di diari degli ultimi dieci anni facilmente accessibili e navigabili, e che sarebbe forse un peccato perdere del tutto. Allo stesso tempo, molte delle cose davvero importanti che sono successe nella mia vita, e come io ho reagito e quello che io ho provato, non sono lì. Sono state troppo intime, le ho protette. E non è che le abbia scordate.
Varrà la pena continuare a rifletterci, immagino.
* Durante la stesura di questo post, abbiamo ricevuto l'inaspettata e fantastica notizia per cui il limite passerà da 25 a 50 giga durante questa settimana. La giuoia, non potete capire la giuoia!
Giorno 1
"Ho addirittura anticipato l'attuazione rispetto alla deadline stabilita. Momento di panico subito prima di cliccare su 'disattiva': sarà davvero una misura solo temporanea? G., per non rischiare, mi propone la soluzione alternativa di cambiare lui la mia password. Eh no, cavolo, deve essere una cosa che faccio da me. Ricontrollo la procedura (mi sento ridicola). Nel frattempo Facebook cerca in tutti i modi di convincermi a non farlo, puntando anche sul senso di colpa ('a questi amici mancherai!') o proponendo soluzioni più blande.
Scopro che per riattivare gli account del gruppo Facebook, basta semplicemente riaccedervi: mi sembra una misura un po' debole. Scopro anche che Twitter, dopo 30 giorni di sospensione, elimina definitivamente l'account. Promemoria sul Calendar, servirà un breve accesso anticipato.
Sera, G. è ri-partito. Incredibilmente, mi sembra di avere moltissimo tempo in più a disposizione tra le mani, senza social. Quasi troppo."
Giorno 2
"Le mie dita cercano automaticamente di accedere alle applicazioni sul telefono (disinstallate): quante migliaia di volte avrò compiuto lo stesso gesto, per farglielo fare quando sono sovrappensiero?"
Giorno 3
"Quando sono al computer, il mouse finisce spesso a cercare il link diretto a Facebook (cancellato).
N.B. dormo meglio."
Giorno 4
"Per lavoro devo contattare un ex dottorando. Non ho il suo nuovo indirizzo e-mail, ma siamo amici su Facebook. Oh-oh.
Meno male che ho lasciato l'accesso a Messenger."
Giorno 5
"È tornato il controllo sull'utilizzo dei dati. Addio."
Questo ha bisogno di qualche spiegazione: essendo in una residenza dell'Università, la rete internet è, sorpresa!, gestita dall'Università. C'è un limite di consumo dati, fissato a 25 Giga ogni 8 giorni: superato il limite, l'accesso ad internet è ristretto a siti riguardanti l'ateneo. Ad un certo punto, circa un anno e mezzo fa, un po' per caso avevo by-passato questo problema, ma devono aver aggiornato il sistema e lo stesso espediente non funziona più.
Ora, senza più i social avevo intenzione di ripartire il tempo guadagnato tra letture e recupero di serie su Netflix o di video interessanti su Youtube, ma i 25 Giga scorrono via come acqua. Quindi niente, libri a go-go!*
E poi non ho più annotato nulla: dopo i primi giorni di assestamento, non c'è stato più bisogno.
- Si, ok, ma quindi? In sostanza?
In sostanza, i quaranta giorni sono arrivati e passati, e io ancora non ho riattivato gli account. Sono stata talmente tanto bene senza, che ho quasi paura a rientrare nel circolo vizioso.
Da un punto di vista pratico, l'assenza in particolare di Facebook si è fatta sentire: ci sono stati svariati momenti in cui segnarsi un evento (e ricordarsene!) sarebbe stato molto più facile semplicemente cliccando su "Partecipa". Sono stati numerosi i "ah già, volevo farti vedere questa cosa/giusto, non puoi saperlo/hai visto cosa è successo?". Ma è stato così problematico? Non particolarmente. Forse vale la pena doversi scrivere a mano qualche cosa in più o dover dipendere da altri per avere determinate informazioni, se la ricompensa è un po' di pace interiore.
Psicologicamente parlando, che pacchia!, che rilassatezza! Avrò anche perso degli aggiornamenti sulla vita dei miei contatti, ma quelle due o tre cose importanti che sono successe le ho vissute (da lontano) lo stesso, e con molta più tranquillità. Che poi, quanti di questi aggiornamenti sono davvero importanti? E lo dico anche pensando ai miei, eh! Quante di queste cose vale davvero la pena sapere? Durante questo periodo mi sono chiesta se ci prenderemmo la briga di raccontare a voce in una conversazione tutto ciò che pubblichiamo in giro sulle varie piattaforme, e la risposta è che probabilmente no. Potrebbe essere un buon criterio, un po' per tutti, per discernere ciò che è valido o meno: non che sia una condizione sufficiente, non è obbligatorio condividere cose della propria vita. Ma allora che senso hanno i social?
Mi sto interrogando da un po' sulla questione, e ancora non ho trovato una risposta precisa. Motivo per il quale credo che continuerò a tenere gli account in sospeso sine die: anche qua, che cosa psicologicamente bizzarra. Perché non dovrei eliminarli definitivamente? Immagino ci sia una componente legata al fatto di avere delle sorte di diari degli ultimi dieci anni facilmente accessibili e navigabili, e che sarebbe forse un peccato perdere del tutto. Allo stesso tempo, molte delle cose davvero importanti che sono successe nella mia vita, e come io ho reagito e quello che io ho provato, non sono lì. Sono state troppo intime, le ho protette. E non è che le abbia scordate.
Varrà la pena continuare a rifletterci, immagino.
* Durante la stesura di questo post, abbiamo ricevuto l'inaspettata e fantastica notizia per cui il limite passerà da 25 a 50 giga durante questa settimana. La giuoia, non potete capire la giuoia!